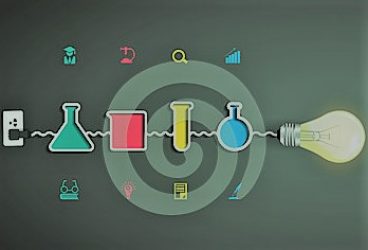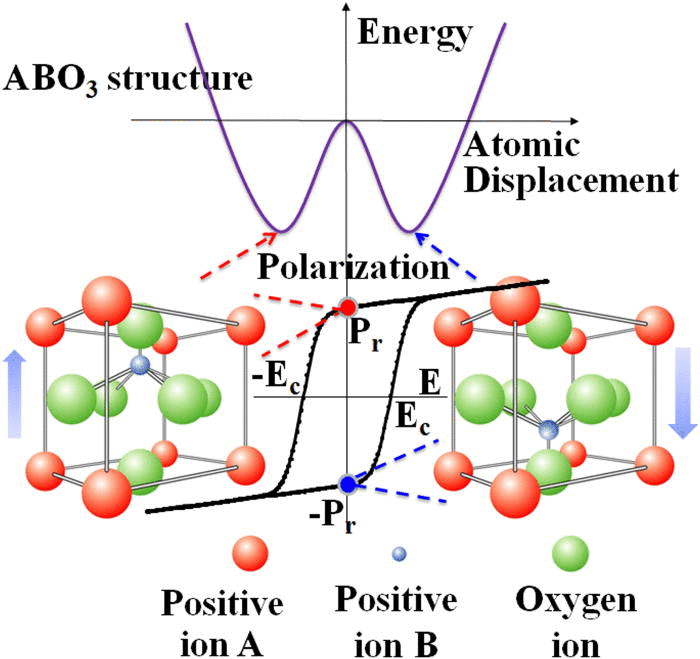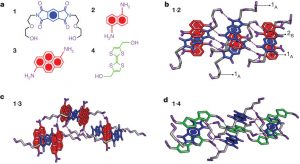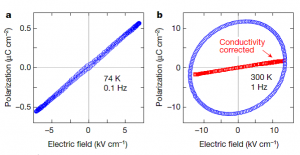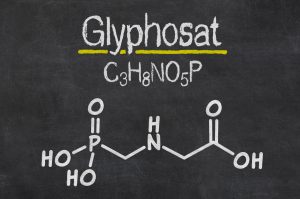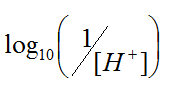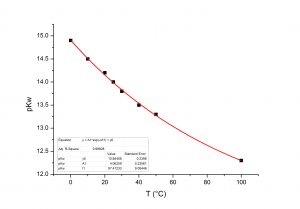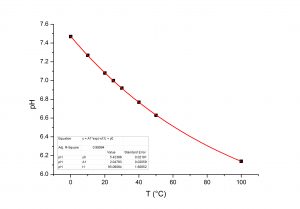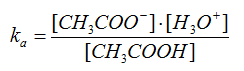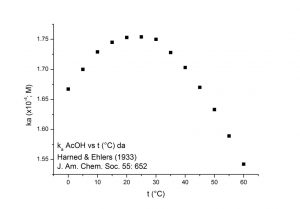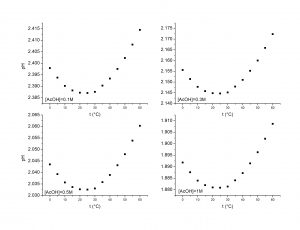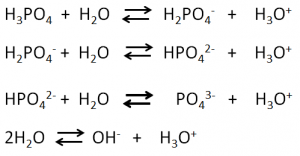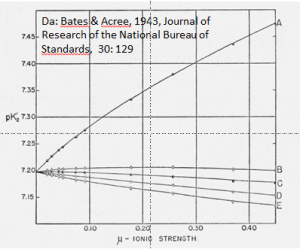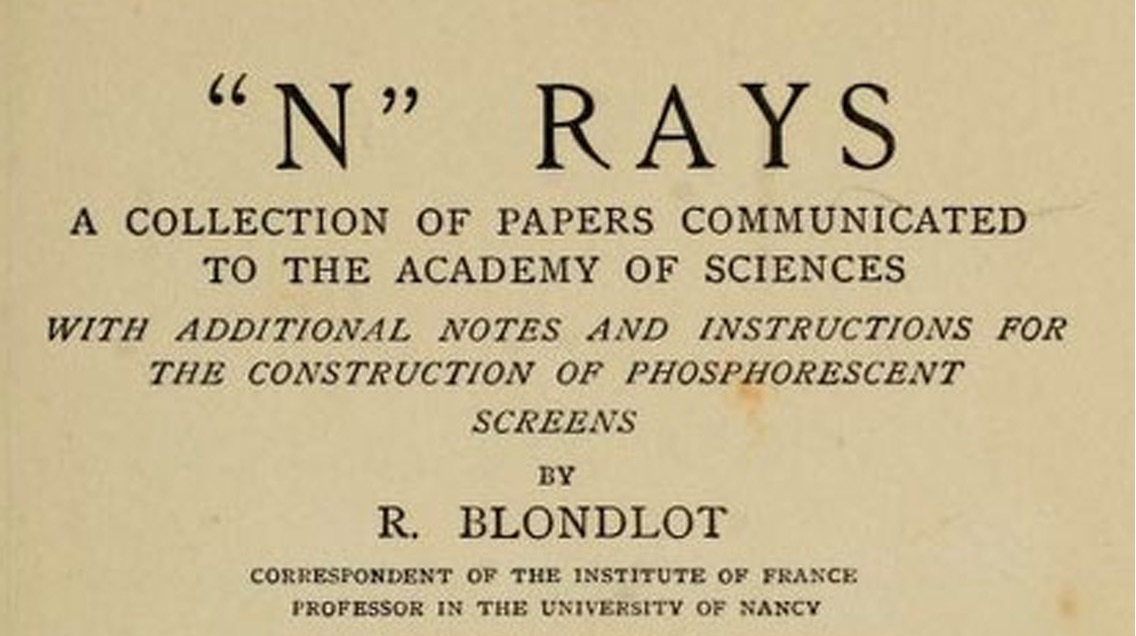Nelle prime due parti di questo reportage scientifico sull’omeopatia ho discusso dei limiti chimici dei modelli proposti da Benveniste e Montagnier (Omeopatia e fantasia. Parte I e Parte II).
Le conclusioni a cui sono giunto indicano chiaramente che sia il lavoro di Benveniste che quello di Montagnier non sono attendibili (Omeopatia e fantasia. Parte I); e non sono attendibili, perché affetti da bias metodologici, nemmeno i lavori che cercano di spiegare la memoria dell’acqua, cavallo di battaglia di chi assume che l’omeopatia funzioni (Omeopatia e fantasia. Parte II).
Nelle conclusioni della seconda parte di questo reportage ho anche evidenziato che sono più che sicuro che gli amici dell’omeopatia non si arrenderanno neanche di fronte alle evidenze più ovvie e diranno che è vero che la memoria dell’acqua non esiste, ma l’omeopatia funziona (ovvero ha effetti) in ogni caso. Si tratta solo di individuare il corretto meccanismo per cui essa ha effetto contro tutte le basi chimiche e biochimiche di cui oggi disponiamo.
Lo scopo di questa terza parte è evidenziare quale sia il reale meccanismo di funzionamento dei rimedi omeopatici.
Effetto placebo
Un placebo è un trattamento – o un farmaco – che non ha alcuno effetto specifico sulle condizioni di salute che vengono studiate durante una sperimentazione.
“Effetto placebo” è una locuzione che indica un qualsiasi cambiamento positivo (nel caso di un cambiamento negativo si parla di “effetto nocebo”) nello stato di salute di un paziente come conseguenza di un’azione aspecifica non attribuibile ad alcun trattamento o farmaco.
Perché un trattamento possa avere un effetto placebo, il paziente deve essere in stato di veglia e cosciente. In caso contrario, l’effetto placebo non si osserva.
La storia delle origini della medicina è ricca di trattamenti aspecifici la cui efficacia terapeutica, alla luce delle conoscenze odierne, era nulla. Per questo motivo possiamo dire che la medicina di 100-150 anni fa era lo studio e l’osservazione degli effetti placebo.
Omeopatia ed effetto placebo nella letteratura scientifica
Linde et al. (1997) [1] riportano che dagli 89 studi selezionati tra i 186 pubblicati fino al 1995, si evince che i rimedi omeopatici, statisticamente parlando, sembrano funzionare meglio dei rimedi placebo. Tuttavia, due anni dopo, nel 1999, gli stessi autori [2], dopo aver rivisto i parametri di qualità usati per la scelta degli studi da valutare comparativamente, concludono:
“THE EVIDENCE OF BIAS WEAKENS THE FINDINGS OF OUR ORIGINAL META-ANALYSIS […]. IT SEEMS, THEREFORE, LIKELY THAT OUR META-ANALYSIS AT LEAST OVERESTIMATED THE EFFECTS OF HOMEOPATHIC TREATMENTS”.
In altre parole, gli autori ammettono che in molti degli studi che avevano preso in considerazione per la loro indagine del 1997, sono individuabili dei limiti metodologici che hanno condotto ad una sovrastima della validità dell’omeopatia. Infatti, rimuovendo dall’indagine tutti gli studi meno rigorosi, si conclude che l’efficacia terapeutica dei rimedi omeopatici non è superiore al placebo.
Le conclusioni rivedute e corrette di Linde et al. (1999) [2] sono state confermate anche da Ernst (2002) [3]:
“THE HYPOTHESIS THAT ANY GIVEN HOMEOPATHIC REMEDY LEADS TO CLINICAL EFFECTS THAT ARE RELEVANTLY DIFFERENT FROM PLACEBO OR SUPERIOR TO OTHER CONTROL INTERVENTIONS FOR ANY MEDICAL CONDITION, IS NOT SUPPORTED BY EVIDENCE OF SYSTEMATIC REVIEWS”.
Per cercare di ri-equilibrare una situazione abbastanza sfavorevole per l’omeopatia, Mathie (2003) [4] pubblica una nuova analisi in cui decide di prendere in considerazione lavori pubblicati tra il 1975 ed il 2002 per un totale di 93 studi. La motivazione che spinge Mathie a rifare una meta-analisi con un numero di studi appena più alto di quello preso in considerazione da Linde et al. (1997) [1], è che:
“THE RESULTS OF SEVERAL META-ANALYSES OF CLINICAL TRIALS ARE POSITIVE, BUT THEY FAIL IN GENERAL TO HIGHLIGHT SPECIFIC MEDICAL CONDITIONS THAT RESPOND WELL TO HOMEOPATHY”.
In altre parole, secondo Mathie, le meta-analisi finora pubblicate, pur dimostrando l’efficacia dell’omeopatia (non si sa bene su cosa si basi questa sua convinzione considerando quanto realmente riportato in letteratura), non danno indicazioni sul tipo di patologie per le quali essa risulta maggiormente efficiente. Per questo, egli decide di evidenziare nella sua meta-analisi quali siano le patologie per le quali ci sono state risposte positive oltre il placebo e quali, invece, quelle per le quali le risposte sono state negative al di sotto del placebo.
Le conclusioni a cui Mathie giunge sono che i rimedi omeopatici funzionano meglio del placebo per la diarrea infantile, la fibriomalgia, la rinite allergica, l’influenza, dolori di varia origine, effetti collaterali di chemio- e radio-terapie, distorsioni ed infezioni del tratto respiratorio superiore. L’omeopatia si è, invece, dimostrata inutile per mal di testa, ictus e verruche.
Ciò che in realtà colpisce della meta-analisi di Mathie è che egli non tiene in alcun conto né della rivalutazione che Linde et al. hanno fatto del loro primo studio riportando che le loro precedenti conclusioni avevano sovrastimato gli effetti dei rimedi omeopatici [1, 2], né di quanto riportato da Ernst nel 2002 [3]. In particolare, del lavoro di Ernst, Mathie dice che, date le premesse scelte dall’autore, non si poteva non concludere che l’omeopatia fosse una pratica inutile. Insomma, attribuisce la valutazione negativa che Ernst fa dell’omeopatia al modo con cui quell’autore ha deciso di selezionare e riportare gli studi di riferimento: studi che descrivono l’omeopatia in modo vantaggioso vengono contrapposti ad un ugual numero di lavori in cui l’omeopatia non ha rivelato la sua efficienza. Mediamente, quindi, il peso dei primi viene annullato da quello dei secondi ed il risultato è che l’omeopatia non fa meglio del placebo.
Tuttavia, non si può non evidenziare che la tabella 1 del lavoro di Mathie (2003) [4] riporta il numero di studi presi in considerazione per tipologia di patologia. Per esempio, la diarrea infantile è stata studiata solo in tre lavori, la fibriomalgia in due, le distorsioni in due, gli ictus in due e così via di seguito. Trarre conclusioni in merito all’efficacia o alla non efficacia di un certo trattamento solo sulla base di un numero così esiguo di studi, è quantomeno azzardato. La meta-analisi condotta da Ernst nel 2002 [3] è certamente più significativa sotto l’aspetto statistico.
Nel 2005 compare in letteratura una meta-analisi a firma di Shang e collaboratori [5] che mette un punto definitivo in merito al rapporto tra efficacia dell’omeopatia ed effetto placebo.
Utilizzando 19 database diversi, gli autori individuano 165 studi pubblicati tra il 1995 ed il 2003 da cui ne selezionano 105 sulla base di criteri di inclusione/esclusione che si basano sulla presenza di gruppi di controllo con placebo; sulla descrizione degli esiti clinici dei vari trattamenti; sulla presenza di indicazioni in merito alla scelta randomizzata sia degli individui da inserire nei gruppi di controllo che della somministrazione dei rimedi omeopatici e placebo; sul fatto che i risultati siano apparsi su riviste non predatorie e siano, quindi, stati soggetti ad una seria revisione tra pari (peer review).
Senza entrare troppo nei dettagli tecnici dell’analisi statistica riportata in Shang et al., le principali conclusioni di questi autori sono:
“OUR STUDY POWERFULLY ILLUSTRATES THE INTERPLAY AND CUMULATIVE EFFECT OF DIFFERENT SOURCES OF BIAS. WE ACKNOWLEDGE THAT TO PROVE A NEGATIVE IS IMPOSSIBLE, BUT WE HAVE SHOWN THAT THE EFFECTS SEEN IN PLACEBO-CONTROLLED TRIALS OF HOMEOPATHY ARE COMPATIBLE WITH THE PLACEBO HYPOTHESIS. BY CONTRAST, WITH IDENTICAL METHODS, WE FOUND THAT THE BENEFITS OF CONVENTIONAL MEDICINE ARE UNLIKELY TO BE EXPLAINED BY UNSPECIFIC EFFECTS”.
In definitiva, gli autori evidenziano come gli studi condotti per valutare gli effetti dei rimedi omeopatici siano soggetti a pregiudizi di conferma che impediscono di raggiungere conclusioni oggettive in merito alla distinzione tra effetto reale di tipo biochimico ed effetto placebo. Quest’ultimo, in realtà, è l’ipotesi più semplice e, di conseguenza, più plausibile per spiegare il successo dei rimedi omeopatici.
L’importanza del lavoro di Shang et al. si evince dal tiro incrociato a cui, negli anni, è stato sottoposto dagli amici dell’omeopatia. Per esempio, subito dopo la sua pubblicazione, appaiono su The Lancet – la rivista che ospita lo studio di Shang et al – delle lettere all’editore a firma, la prima, di Walach, Jonas e Lewith [6], la seconda di Linde e Jonas [7], la terza ad opera di una moltitudine di autori tra cui compare Mathie e di nuovo Walach [8].
Sebbene a firme (quasi) differenti, le tre lettere all’editore lamentano tutte di una mancanza di chiarezza da parte di Shang e collaboratori [5] in merito al modo con cui essi hanno deciso di applicare i criteri di inclusione/esclusione e criticando il fatto che le conclusioni sono troppo pessimistiche per l’omeopatia.
Queste critiche vengono mosse nonostante venga indicato, da un lato, che:
“there are, after all, been very few placebo-controlled randomized trials in homeopathy, which is why there is an absence of evidence”
dall’altro che:
“we agree that homeopathy is highly implausible and that the evidence from placebo-controlled trials is not robust”
In altre parole, per gli autori delle lettere anzidette, l’omeopatia funziona nonostante non ci siano evidenze positive al di là di ogni possibile dubbio perché studi in cui viene fatto un confronto con il placebo non ce ne sono ed anche quei pochi pubblicati soffrono di un qualche pregiudizio metodologico.
A mio avviso questa è una posizione veramente antiscientifica. Uno scienziato deve sospendere ogni possibile giudizio se ritiene che non siano presenti dati sufficienti per avallare una posizione o un’altra in merito ad un determinato modello scientifico. Non può dire “questa cosa funziona, sebbene non ci siano prove a sostegno di una tale evidenza” e sulla base di questo criticare uno studio che cerca di fare chiarezza utilizzando il meglio di quanto la ricerca in omeopatia ha finora prodotto.
Gli argomenti della lettera di cui al riferimento [8] sono ripresi in un lavoro pubblicato di Rutten e Stolper (2008) [9].
La critica al lavoro di Shang et al. [5] si basa sul fatto che secondo Rutten e Stolper (2008) [9] la qualità della meta-analisi dipende fortemente dal modo in cui vengono selezionati i criteri di inclusione/esclusione. In particolare, vengono confrontati lo studio di Shang et al. [5] con quello di Linde et al. [1]. La conclusione è che, applicando i criteri riportati da Linde et al. agli studi selezionati da Shang et al. [5], non si può dire, come hanno fatto Shang e collaboratori [5], che l’efficacia dell’omeopatia sia dovuta all’effetto placebo.
Devo dire, come mia personale considerazione, che la lettura del lavoro di Rutten e Stolper [9] mi lascia molto perplesso per la velata disonestà intellettuale dei due autori.
Come mai prendono in considerazione un lavoro scritto nel 1997 che, nel 1999, gli stessi autori (Linde et al. [2]) hanno rielaborato arrivando a scrivere che quanto da loro riportato in precedenza era affetto da una sovrastima dei dati relativi all’efficacia dell’omeopatia? Come mai non hanno mai citato il lavoro scritto da Linde et al. nel 1999 [2]? Leggendo meglio lo studio di Rutten e Stolper [9] noto che il primo si firma “homeopathic physician” ed il secondo come “general practioner, homeopathic physician”, ovvero sono entrambi dei “medici omeopati”, peraltro operanti nella libera professione, ovvero non sono affiliati ad alcuna università o ente di ricerca. Non è che ci sia un conflitto di interessi con la loro attività privata, per cui un lavoro anti-omeopatia apparso su una delle riviste più prestigiose del mondo medico (ovvero il lavoro di Shang e collaboratori pubblicato su The Lancet [5]) dia molto fastidio e debba essere in qualche modo “smontato” cercando di intaccarne la credibilità con ogni mezzo possibile, anche attraverso un opportuno “cherry picking”?
Il sospetto di “cherry picking” si rinforza quando si legge il lavoro apparso su Journal of Clinical Epidemiology [10] di cui uno degli autori è lo stesso Rutten del cui studio ho discusso fino ad ora. Infatti, nello studio a firma di Lüdtke e Rutten [10] non solo si citano entrambi i lavori di Linde et al. [1, 2] (prova che Rutten conosce l’esistenza della rivalutazione fatta nel 1999 da Linde et al.[2] ma volutamente non la prende in considerazione), ma si conclude anche che:
“Our results do neither prove that homeopathic medicines are superior to placebo nor do they prove the opposite”.
Insomma, a quanto pare anche Rutten e Stolper [10] non sono in grado di poter dire che l’efficacia dei rimedi omeopatici possa andare oltre l’effetto placebo.
Nel 2010 appaiono in letteratura altre meta-analisi a firma di Teixeira et al. [11], Nuhn et al. [12] ed Ernst [13] in cui ancora una volta viene ribadito che l’efficacia dell’omeopatia è attribuibile all’effetto placebo.
Le stesse conclusioni sono riportate in un lavoro di Mathie pubblicato nel 2014 [14] ed in uno a firma di Unlu et al. appena apparso on line sul sito del Journal of Oncological Sciences [15]. In particolare, in quest’ultimo lavoro non solo viene evidenziata l’inutilità dell’omeopatia nella cura di patologie come i tumori, ma viene riportato anche che i rimedi omeopatici possono essere tossici se non preparati nel modo adeguato. Infatti, per molti rimedi sono state riscontrate tracce non omeopatiche di contaminanti che hanno portato a problemi gastrointestinali, melanosi ed epatite.
Conclusioni
Dalla breve disanima qui riportata si comprende che non c’è discussione. I rimedi omeopatici hanno un effetto che equivale a quello di un qualsiasi placebo. Se vi sentite bene dopo aver assunto un rimedio omeopatico non è perché ci sia stato un qualche effetto di carattere biochimico. La vostra patologia sarebbe passata anche bevendo un semplice bicchiere di acqua e facendovi credere che esso sia stato toccato dalla bacchetta magica di Harry Potter.
Ma la storia non è certamente finita. L’ultima opposizione degli amici dell’omeopatia è che l’effetto placebo non può essere osservato sugli animali e sui bambini. Quindi ci deve essere qualcosa che non va in tutto quello che sto scrivendo. Questo sarà l’oggetto della quarta parte di questo reportage sull’omeopatia.
Riferimenti
[1] K. Linde et al. (1997) Are the clinical effects of homeopathy placebo effects? A meta-analysis of placebo-controlled trials, The Lancet, 350: 834-843
[2] K. Linde et al. (1999) Impact of study quality on outcome in placebo-controlled trials of homeopathy, Journal of Clinical Epidemiology, 52: 631-636
[3] E. Ernst (2002) A systematic review of systematic reviews of homeopathy, Journal of Clinical Pharmacology, 54: 577-582
[4] R.T. Mathie (2003) The research evidence base for homeopathy: a fresh assessment of the literature, Homeopathy, 92: 84-91
[5] A. Shang et al. (2005) Are the clinical effects of homeopathy placebo effects? Comparative study of placebo-controlled trials of homeopathy and allopathy, The Lancet, 366: 726-732
[6] H. Walach et al. (2005) The Lancet, 366: 2081
[7] K. Linde e W. Jonas (2005) The Lancet, 366: 2081-2082
[8] AA. VV. (2005) The Lancet, 366: 2082
[9] A.L.B. Rutten, C.F. Stolper (2008) The 2005 meta-analysis of homeopathy: the importance of post-publication data, Homeopathy, 97: 169-177
[10] R. Lüdtke, A.L.B. Rutten (2008) The conclusions on the effectiveness of homeopathy highly depend on the set of analysed trials, Journal of Clinical Epidemiology, 61: 1197-1204
[11] M.Z. Teixeira et al. (2010) The placebo effect and homeopathy, Homeopathy, 99: 119-129
[12] T. Nuhn et al. (2010) Placebo effect sizes in homeopathic compared to conventional drugs – a systematic review of randomised controlled trials, Homeopathy, 99: 76-82
[13] E. Ernst (2010) Homeopathy: what does the “best” evidence tell us? The Medical Journal of Australia, 192: 458-460
[14] R.T. Mathie et al (2014) Randomised placebo-controlled trials of individualised homeopathic treatment: systematic review and meta-analysis, Systematic Reviews, 3: 142
[15] A. Unlu et al. (2017) Homeopathy and cancer, Journal of Oncological Sciences, http://dx.doi.org/10.1016/j.jons.2017.05.006
Fonte dell’immagine di copertina: http://www.ilpost.it/2015/03/12/omeopatia-inutile/