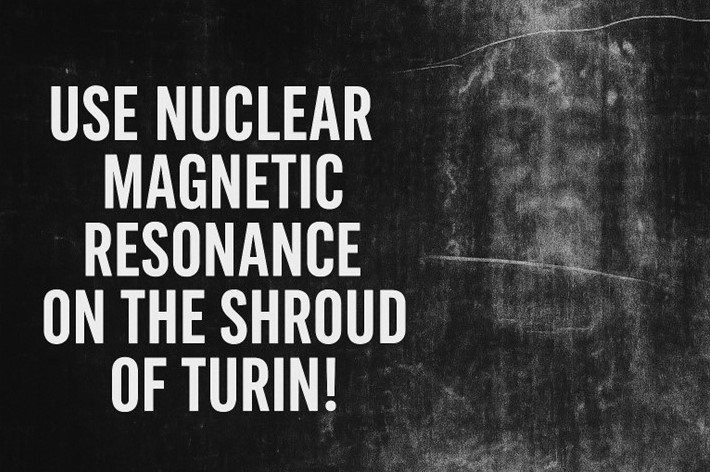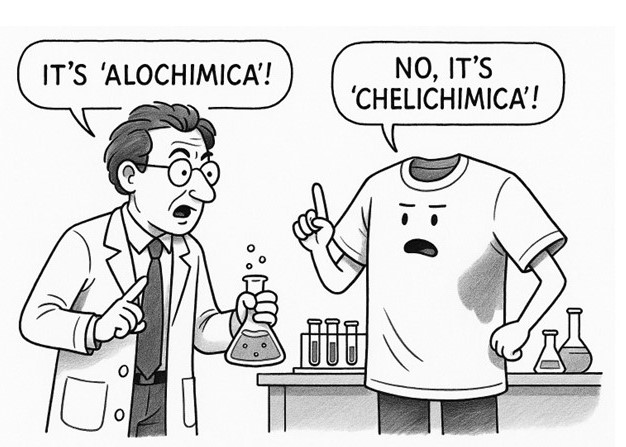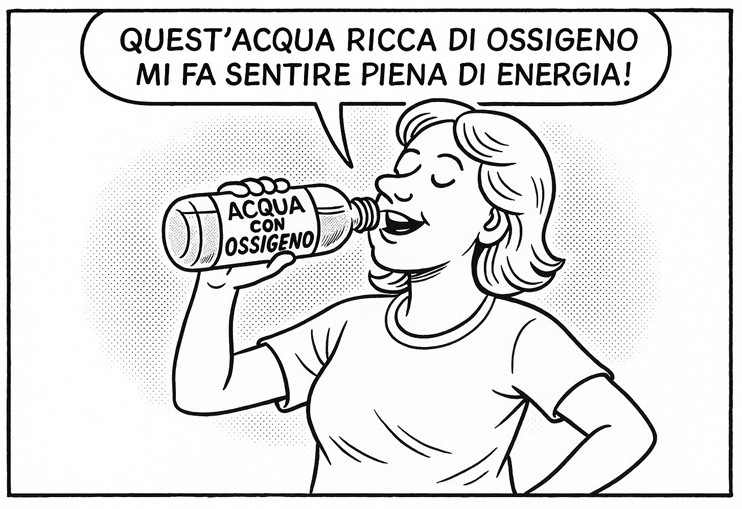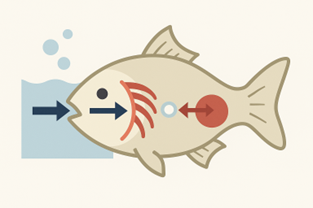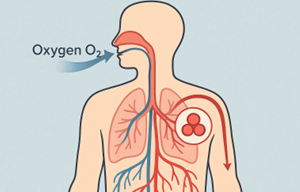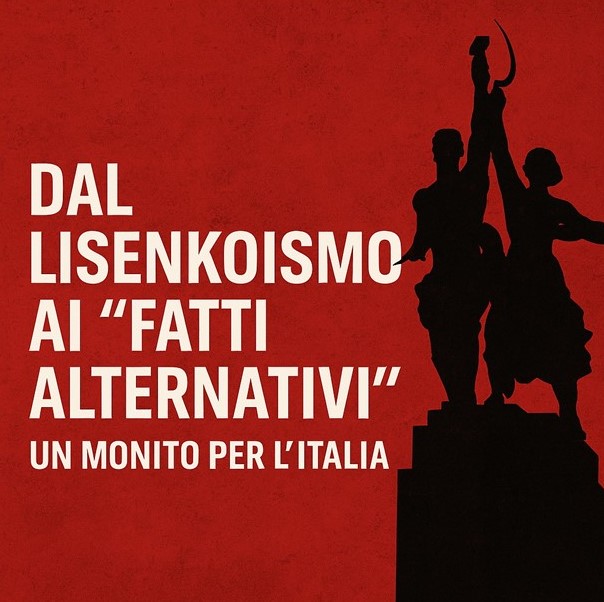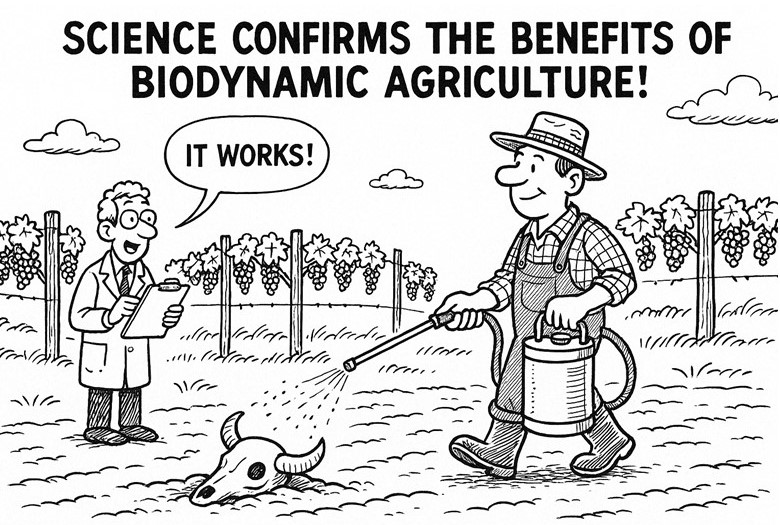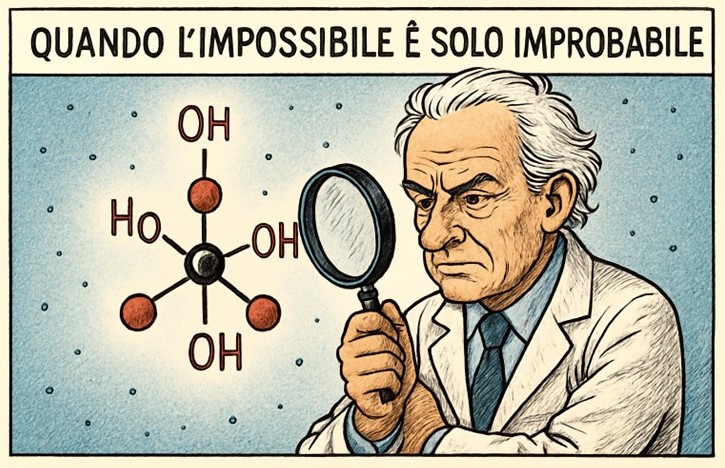Ormai lo sanno anche le pietre: mi occupo di risonanza magnetica nucleare su matrici ambientali. Tradotto per i non addetti: uso la stessa tecnica che in medicina serve a vedere dentro il corpo umano, ma applicata a tutt’altro – suoli, sostanza organica naturale, piante e materiali inerti. Ripeto: non corpi umani né animali, ma sistemi ambientali.
C’è un dettaglio curioso. I medici hanno tolto l’aggettivo “nucleare” dal nome, per non spaventare i pazienti. Peccato che, senza quell’aggettivo, l’espressione “risonanza magnetica” non significhi nulla: risonanza di cosa? elettronica, fotonica, nucleare? Io, che non ho pazienti da rassicurare, preferisco chiamare le cose con il loro nome: risonanza magnetica nucleare, perché studio la materia osservando come i nuclei atomici interagiscono con la radiazione elettromagnetica a radiofrequenza.
Non voglio dilungarmi: non è questa la sede per i dettagli tecnici. Per chi fosse curioso, rimando al mio volume The Environment in a Magnet edito dalla Royal Society of Chemistry.
Tutto questo per dire che in fatto di risonanza magnetica nucleare non sono proprio uno sprovveduto. Me ne occupo dal 1992, subito dopo la laurea in Chimica con indirizzo Organico-Biologico. All’epoca iniziai a lavorare al CNR, che aveva una sede ad Arcofelice, vicino Pozzuoli, in provincia di Napoli. È lì che cominciai a usare l’NMR per studiare la relazione struttura-attività dei metaboliti vegetali: un banco di prova perfetto per capire quanto questa tecnica potesse rivelare.
Successivamente passai all’Università degli Studi di Napoli Federico II, dove estesi l’uso della risonanza magnetica nucleare non solo alla fase liquida, ma anche a quella solida e semisolida. Non più soltanto metaboliti vegetali, dunque, ma matrici molto più complesse dal punto di vista chimico: il suolo e la sostanza organica ivi contenuta.
Con il mio trasferimento all’Università di Palermo ho potuto ampliare ulteriormente le competenze in NMR: dall’uso di strumenti a campo magnetico fisso sono passato allo studio delle stesse matrici naturali con spettrometri a campo variabile. Un passo avanti che mi ha permesso di guardare i sistemi ambientali con ancora più profondità e sfumature.
Ed eccomi qui, dopo più di trent’anni di esperienza, a spiegare perché chi immagina di usare la risonanza magnetica nucleare sulla Sindone di Torino forse ha una visione un po’… fantasiosa della tecnica.
Andiamo con ordine.
La Sindone di Torino: simbolo religioso e falso storico
La Sindone
La Sindone di Torino è un lenzuolo di lino lungo circa quattro metri che reca impressa l’immagine frontale e dorsale di un uomo crocifisso. Per il mondo cattolico rappresenta una delle reliquie più importanti: secondo la tradizione, sarebbe il sudario che avvolse il corpo di Cristo dopo la crocifissione. Attorno ad essa si è sviluppato un culto popolare immenso, fatto di pellegrinaggi e ostensioni pubbliche che ne hanno consacrato il valore spirituale.
Ma che cosa ci dice la scienza su questo straordinario manufatto?
La datazione al radiocarbonio
Il dato più solido arriva dalla datazione con il radiocarbonio. Nel 1988 tre laboratori indipendenti – Oxford, Zurigo e Tucson – pubblicarono sulla rivista Nature i risultati delle loro analisi: il lino della Sindone risale a un periodo compreso fra il 1260 e il 1390 d.C., cioè in piena epoca medievale (Damon et al., 1989). La conclusione degli autori fu inequivocabile: “evidence that the linen of the Shroud is mediaeval”.
Riproduzioni sperimentali
A rafforzare questa interpretazione è intervenuto anche il lavoro del chimico Luigi Garlaschelli, che ha realizzato una riproduzione della Sindone utilizzando tecniche compatibili con l’arte medievale: applicazione di pigmenti su un rilievo, trattamenti acidi per simulare l’invecchiamento, lavaggi parziali per attenuare il colore. Il risultato, esposto in varie conferenze e mostre, mostra come un artigiano del Trecento avrebbe potuto ottenere un’immagine con molte delle caratteristiche dell’originale (Garlaschelli, 2009).
Le conferme della storia
Anche le fonti storiche convergono. Un documento recentemente portato alla luce (datato 1370) mostra che già all’epoca un vescovo locale denunciava il telo come un artefatto, fabbricato per alimentare un culto redditizio (RaiNews, 2025). Questo si aggiunge al più noto documento del 1389, in cui il vescovo di Troyes, Pierre d’Arcis, scriveva a papa Clemente VII denunciando la falsità della reliquia.
Le contro-argomentazioni sindonologiche
Naturalmente, chi sostiene l’autenticità della Sindone non è rimasto in silenzio. Le principali obiezioni riguardano:
- Il campione del 1988 – secondo alcuni, la zona prelevata sarebbe stata contaminata da un rammendo medievale, o comunque non rappresentativa dell’intero telo (Karapanagiotis, 2025).
- L’eterogeneità dei dati – alcuni statistici hanno osservato che i tre laboratori non ottennero risultati perfettamente omogenei, segnalando possibili anomalie (Karapanagiotis, 2025).
- Eventi successivi – l’incendio di Chambéry del 1532, o la formazione di patine microbiche, avrebbero potuto alterare la concentrazione di carbonio-14, facendo sembrare il tessuto più giovane (Karapanagiotis, 2025).
Sono ipotesi discusse ma che non hanno mai trovato prove decisive: nessuna spiegazione è riuscita a giustificare in modo convincente come un tessuto del I secolo potesse apparire medievale a tre laboratori indipendenti.
Le nuove analisi ai raggi X
Negli ultimi anni si è parlato di nuove tecniche di datazione basate sulla diffusione di raggi X ad ampio angolo (WAXS). L’idea è di valutare il grado di cristallinità della cellulosa del lino: più il tessuto è antico, maggiore è la degradazione della sua struttura cristallina. Applicata a un singolo filo della Sindone, questa metodologia ha suggerito un’età più antica di quella medievale (De Caro et al., 2022).
Tuttavia, i limiti sono evidenti: si è analizzato un solo filo, e la cristallinità della cellulosa dipende non solo dal tempo, ma anche da condizioni ambientali come umidità, calore o contatto con sostanze chimiche. Inoltre, il metodo è recente e richiede ulteriori validazioni indipendenti. In sintesi: interessante come indicatore di degrado, ma non ancora un’alternativa solida al radiocarbonio.
Una nuova frontiera? L’NMR
Accanto a tutto ciò è emersa anche la proposta di applicare la risonanza magnetica nucleare (NMR) alla Sindone (Fanti & Winkler, 1998). Alcuni autori suggeriscono che questa tecnica possa rivelare “concentrazioni atomiche” di idrogeno, carbonio o azoto nel telo, o addirittura produrre mappe tomografiche.
Nel prossimo paragrafo entrerò nel dettaglio di questa prospettiva “NMR”, analizzando perché, alla luce dell’esperienza maturata in oltre trent’anni di lavoro su queste tecniche, considero queste proposte non solo irrealistiche, ma anche profondamente fuorvianti.
I limiti della prospettiva NMR
Tra le tante proposte avanzate negli anni, c’è anche quella di usare la risonanza magnetica nucleare per studiare la Sindone. Nel lavoro di Giulio Fanti e Ulf Winkler si ipotizza di applicare tecniche NMR per “vedere” la distribuzione di atomi come idrogeno, carbonio e persino azoto sul telo, o addirittura per ottenere mappe tomografiche simili a quelle della risonanza magnetica medica. Sulla carta può sembrare affascinante, ma nella pratica questa prospettiva presenta numerosi limiti.
Nel caso dei protoni (1H), ad esempio, gran parte del segnale in un lino asciutto deriva dall’acqua residua o da componenti volatili: un parametro che può variare fino all’80% semplicemente cambiando le condizioni ambientali. Inoltre, in un solido come il lino della Sindone, l’analisi 1H-NMR non offre risoluzione: lo spettro mostra soltanto due contributi sovrapposti, un picco stretto e intenso dovuto alle zone cristalline della cellulosa e una larga campana sottostante, tipica delle frazioni amorfe. È chiaro, quindi, che non solo è arduo quantificare i protoni, ma è del tutto irrealistico pensare di usarli per una datazione del tessuto.
Per quanto riguarda l’analisi al carbonio-13 (13C), ci sono diversi punti da sottolineare. La tecnica più usata è la CPMAS 13C-NMR: in questo caso una piccola quantità di campione, dell’ordine dei milligrammi, viene inserita in un porta-campioni invisibile all’NMR, posto nel campo magnetico secondo una geometria precisa, e il carbonio viene “visto” sfruttando l’abbondanza dei protoni. Si tratta però di una tecnica qualitativa: non consente una vera quantificazione del nucleo osservato. Inoltre, richiede tempi di misura molto lunghi, con costi elevati e il rischio concreto di non ottenere informazioni davvero utili.
L’alternativa sarebbe la DPMAS 13C-NMR. Qui, a differenza della CPMAS, non ci si appoggia ai protoni e quindi bisogna fare affidamento solo sull’abbondanza naturale del 13C, circa l’1%: troppo bassa. Di conseguenza i tempi macchina si allungano ulteriormente, con dispendio sia di tempo sia economico. E in più la tecnica è priva di risoluzione: i segnali dei diversi nuclei si sovrappongono in un unico inviluppo indistinguibile, rendendo impossibile perfino la stima del rapporto fra cellulosa cristallina e amorfa.
Quanto all’azoto-14 (14N), il nucleo è quadrupolare e produce linee larghissime e difficilmente interpretabili: in pratica, misure affidabili non sono realistiche.
Nel lavoro di Fanti e Winkler, ci sono poi anche problemi di coerenza interna. Nel testo, ad esempio, si ipotizzano tempi di rilassamento e acquisizione non compatibili con i valori sperimentali reali, e si propongono scenari come la “tomografia NMR dell’intero telo” che, per un materiale rigido e povero di mobilità come il lino secco, sono semplicemente impraticabili: i tempi di decadimento del segnale sono troppo brevi perché si possa ricostruire un’immagine come in risonanza magnetica medica.
Infine, il lavoro suggerisce di estendere le misure addirittura a mappature di radioattività con contatori Geiger o a esperimenti di irraggiamento con neutroni, ipotizzando collegamenti con la formazione dell’immagine. Si tratta di congetture prive di fondamento sperimentale, più vicine a un esercizio di fantasia che a un protocollo scientifico realistico.
In sintesi, Fanti e Winkler hanno portato il linguaggio della NMR nel dibattito sulla Sindone, ma le applicazioni che propongono si scontrano con limiti tecnici insormontabili e interpretazioni sbagliate.
L’NMR è uno strumento potentissimo per lo studio di suoli, sostanza organica e sistemi complessi, ma applicarlo alla Sindone nei termini proposti non ha basi scientifiche solide: rischia anzi di trasformare una tecnica seria in un’arma retorica al servizio di ipotesi precostituite.
Conclusioni
Alla fine dei conti, la Sindone di Torino resta ciò che la scienza ha già dimostrato da tempo: un manufatto medievale. Lo dice la datazione al radiocarbonio pubblicata su Nature; lo confermano le riproduzioni sperimentali di Luigi Garlaschelli e i documenti storici del Trecento che la denunciavano come artefatto devozionale; lo ribadiscono i limiti delle nuove tecniche “alternative” che, per quanto presentate come rivoluzionarie, non hanno mai scalfito la solidità del verdetto del 1988. Le contro-argomentazioni dei sindonologi — campioni non rappresentativi, rammendi invisibili, incendi o contaminazioni miracolose — sono ipotesi suggestive, ma prive di prove concrete e incapaci di spiegare perché tre laboratori indipendenti abbiano ottenuto lo stesso responso: Medioevo. Le proposte più recenti, come l’uso dei raggi X o addirittura della risonanza magnetica nucleare, non fanno che spostare il problema, avanzando idee tecnicamente fragili e spesso concettualmente errate.
La Sindone rimane dunque un oggetto straordinario, ma non perché testimoni la resurrezione di Cristo: straordinaria è la sua forza simbolica, straordinaria è la devozione che suscita, straordinaria è la capacità che ha avuto per secoli di alimentare fede, immaginazione e perfino business. Ma sul piano scientifico la questione è chiusa. Continuare a spacciarla per “mistero insoluto” significa ignorare le evidenze e trasformare la ricerca in propaganda. E questo, più che un atto di fede, è un insulto all’intelligenza.