Preludio.
È da un po’ di tempo che non scrivo articoli nel blog. Non c’è un motivo particolare se non quello relativo al fatto che penso che troppo presenzialismo sia nocivo: trovo molto più utile scrivere quando ho qualcosa di curioso ed interessante da raccontare come in questo caso. Ho deciso di aprire una nuova rubrica dedicata alle persone straordinarie che ho avuto la fortuna di incontrare nella mia vita.
Da dove parto? Da Cristina Fazzi.
Brevi note biografiche.
Molti di voi si chiederanno chi sia mai Cristina Fazzi. È un medico. Si è laureata in chirurgia a Catania e, dopo alcune esperienze nella sua Sicilia, ha deciso, per puro caso, di trasferirsi in Zambia dove aiuta come medico le popolazioni locali. Ha dato vita ad una ONG che si occupa, tra le tante cose, di trovare fondi e gestire progetti per costruire ospedali ed ambulatori nelle zone più o meno accessibili dello Zambia. Ha adottato un bambino (oggi giovane uomo) in Zambia e, grazie alla sua determinazione, è stata capace di aprire la strada – in realtà ancora impervia – alle adozioni dei single in Italia. Infatti, per circa tre anni ha portato avanti una battaglia per far riconoscere l’adozione del suo Joseph – del tutto regolare in Zambia – anche in Italia; e ci è riuscita. Ad oggi ha in affido altri sette bambini Zambiani che sta crescendo con grande amore.
Ma non è delle sue avventure di mamma single che voglio parlarvi. Né voglio illustrarvi le peripezie che si è trovata a vivere e che tuttora vive in Zambia per la realizzazione dei suoi progetti umanitari. Tutto questo lo potete leggere nella sua biografia dal titolo “Karìbu. Lo Zambia, una donna, una grande avventura” scritto a quattro mani con Lidia Tilotta (qui).
I miei ricordi.
Ho avuto modo di incontrare la dottoressa Fazzi in occasione della presentazione del suo libro al Policlinico di Palermo. Ho partecipato a quell’incontro spinto da un mio collega che, sentendomi parlare del biochar, oggetto, come ben sapete, della mia attività di ricerca, ha pensato che fosse utile una mia partecipazione alla presentazione del libro di Cristina Fazzi e Lidia Tilotta. Non avevo eccessive aspettative, in realtà. Pensavo che sarebbe stata la solita presentazione noiosa con gli autori che fanno la solita passerella per promuovere il solito libro dalla tiratura limitata destinato ad essere la solita meteora nel panorama della letteratura divulgativa del nostro paese. Ed invece…
Invece è stata un’illuminazione. Non appena la Dottoressa Fazzi ha cominciato a raccontare perché si è trasferita in Zambia mi sono venuti in mente i racconti di mio padre che negli anni Trenta del secolo scorso (sì, mio padre nacque nel 1922 e quest’anno, fosse stato ancora in vita, avrebbe compiuto 100 anni. Un’età ragguardevole. Ma, per un figlio, un genitore non ha mai un’età ragguardevole e dovrebbe essere immortale…ma questo non c’entra con quanto voglio scrivere) si trasferì assieme ad alcuni zii nell’Eritrea italiana in cerca di opportunità di lavoro. Lì fu fatto prigioniero dagli inglesi (come il nonno della dottoressa Fazzi) e, campo di concentramento dopo campo di concentramento, sopravvisse, prigioniero, fino al 1946, anno in cui fu liberato e, pesando una quarantina di chili scarsi, tornò in Italia. Nonostante le sue traversie, egli ha sempre raccontato del suo mal d’Africa e della nostalgia che quel continente gli provocava. Ovviamente, la storia di mio padre non c’entra nulla con la dottoressa Fazzi. Il punto è che la dottoressa, col suo incipit, mi ha portato alla mente tante cose e mi ha commosso. Mi ha commosso non solo perché ha fatto emergere dalla profondità dei miei ricordi cose che erano sedimentate e messe da parte perché, nonostante la mia età, non ho ancora superato la perdita di mio padre, ma anche perché mi ha illuminato e reso veramente chiaro il concetto di “aiutiamoli a casa loro”.
Aiutiamoli a casa loro. Parte I
Vi ricorda qualcosa questa locuzione? Ormai va di moda. E pur di “aiutarli a casa loro” raccogliamo qualsiasi cosa e, sotto forma di aiuti umanitari, mandiamo tutto nei paesi in via di sviluppo, convinti che quanto “racimoliamo” possa davvero essere utile. In realtà, questa è un’operazione che serve solo a noi stessi. Serve per lenire i sensi di colpa che ci attanagliano perché sappiamo benissimo che, per usare tutte le comodità di cui disponiamo, deprediamo le risorse naturali di paesi lontanissimi da noi rendendoli sempre più poveri.
Come ha raccontato la dottoressa Fazzi, a cosa mai potranno servire gli omogeneizzati nelle zone povere dei paesi africani, tra cui lo Zambia? Perché sto citando gli omogeneizzati? Perché uno dei racconti della dottoressa Fazzi ha riguardato il rifiuto da parte sua di un carico di aiuti umanitari fatto da omogeneizzati.
Gli omogeneizzati.
Sappiamo tutti che cosa sono gli omogeneizzati. Sappiamo benissimo che sono utilissimi per lo svezzamento dei bambini e per ottimizzare la loro crescita. Eppure, in Zambia – ma anche negli altri paesi poveri – questa tipologia di prodotti è inutile: in questi paesi non è possibile produrre omogeneizzati. Quindi, una volta consumati, le popolazioni locali non avrebbero più cibo utile per lo svezzamento dei bambini. Ed allora? Dovrebbero attendere altri aiuti ed altri ancora in un loop infinito che non farebbe altro che implementare la loro dipendenza dai paesi più ricchi dell’emisfero.
Aiutiamoli a casa loro. Parte II
“Aiutiamoli a casa loro”, quindi, significa rimboccarsi le maniche e andare lì, nei paesi poveri, per insegnare a quelle popolazioni a usare al meglio le risorse disponibili in loco. Esattamente come sta facendo la dottoressa che ha costruito non so più quanti pozzi e quanti ambulatori/cliniche/ospedali per “aiutare a casa loro” persone che vivono ai margini del mondo moderno. Meglio ancora se, accanto alle opere fisiche, si provvede anche all’educazione, cioè alla corretta divulgazione scientifica per convincere le popolazioni locali della inutilità delle superstizioni utili solo formalmente ma non sostanzialmente alla sopravvivenza in zone veramente impervie del globo.
Come ha sapientemente evidenziato la dottoressa Fazzi, se “riesco ad istruire 10 persone delle popolazioni locali sulla utilità dei vaccini nella prevenzione delle malattie, queste 10 persone a loro volta potranno convincere, ognuna, altre 10 persone e così via di seguito, fino ad arrivare a una situazione in cui la conoscenza potrà ricacciare indietro le credenze tribali e fornire le basi per il reale sviluppo del paese” (ho virgolettato le parole che, però, riportano i concetti espressi dalla dottoressa Fazzi).
Educare.
Alla luce di quanto espresso, l’educazione deve giocare un ruolo primario per “aiutare a casa loro” le persone che vivono in condizioni estreme. L’educazione, però – e questa è una mia considerazione personale che viene dall’aver conosciuto la dottoressa Fazzi – deve riguardare non solo le popolazioni locali, ma anche noi. Dobbiamo imparare che non è sgravandoci la coscienza dai sensi di colpa mediante l’invio di qualsiasi cosa nei paesi in via di sviluppo che possiamo risolvere i loro problemi. Dobbiamo imparare ad ascoltare le persone come la dottoressa Fazzi per capire quali sono le reali esigenze delle popolazioni locali e quali sono le loro risorse naturali. Sono queste ultime a dover essere messe al centro dell’attenzione per poter consentire un vero sviluppo culturale e “fisico” di popoli poveri quali quello dello Zambia.
E la ricerca scientifica?
E questo è il punto, adesso. Cosa facciamo noi in concreto per aiutare i paesi come lo Zambia? L’Agraria di Palermo ha cercato e cerca di operare nei paesi in via di sviluppo per “aiutare a casa loro” le popolazioni locali.
Agli inizi degli anni ’10 di questo secolo è stato sviluppato il progetto Burundi (qui) grazie al quale la professionalità dei docenti dell’attuale Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Forestali è stata messa a disposizione per la realizzazione di opere concrete affinché le popolazioni locali potessero “crescere” da sole utilizzando le risorse locali.
Poco prima della pandemia del 2020, lo stesso Dipartimento ha realizzato una convenzione col vescovado di Mbulu in Tanzania per la realizzazione di un video divulgativo da diffondere tra le popolazioni del posto in modo da spiegare come risolvere i problemi più comuni legati alle tecniche agricole locali.
Io stesso faccio parte di un gruppo di ricerca internazionale che qualche anno fa ha condotto delle sperimentazioni in Nepal per valutare l’efficienza del biochar nell’aumentare la produzione agricola locale (qui). In particolare, abbiamo potuto verificare che il biochar (se volete sapere che cos’è basta cliccare qui) prodotto con residui vegetali locali (qui per sapere come si produce il biochar in zone in via di sviluppo) e funzionalizzato con urina di vacca, era in grado di incrementare di quattro volte la produzione di zucca.
Potremmo fare altro? Certo che sì. Potremmo fare molto di più che progetti estemporanei che si concretizzano con elaborati utili allo sviluppo di tesi di laurea o di pubblicazioni su riviste più o meno qualificate. Tuttavia, questo richiede non solo la volontà personale di ognuno di noi, ma anche una vera e propria coordinazione globale che coinvolga sia le autorità italiane che quelle dei paesi in via di sviluppo in modo da supportare le attività dei ricercatori ed evitare le esperienze negative molto ben descritte nel libro della dottoressa Fazzi.

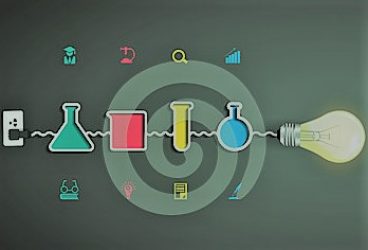

Ho letto il libro “Karbu” benvenuti Eccezionale! Vita vissuta, esperienze uniche Sono stato 4 volte in Terra d’Africa, l’Africa nera, l’Africa povera Ho visto delle realtà inimmaginabili, non descrivibile. Mi complimento cn la Dr.ssa , Collega e mi permetto di fare una osservazione La scelta di andare in Africa non l’ha fatta Lei bensì un essere superiore per farle realizzare un sogno e un desiderio: adottare Joshef. Una volta un signore mi ha detto: quando salvi una vita hai fatto quello che il Signire desidera. Noi siamo il braccio di chi si serve di noi per fare del bene Amante… Leggi il resto »